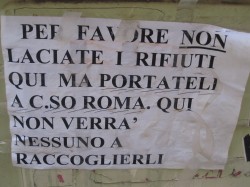di Anna Maria Di Miscio
(grazie)
 Foggia – I LUOGHI della politica, dei partiti e delle istituzioni, del quotidiano tra le mura domestiche hanno sempre riprodotto la divisione dei ruoli f/m, data per scontata, un dato della natura. È così che il corpo della donna si fa supporto delle iscrizioni della cultura: limitati sono gli spazi del piacere e della sessualità, delle emozioni, delle ambizioni, della gratificazione e realizzazione di un progetto di vita, se non all’interno di ruoli ascritti a vita. I diktat imposti dalla cultura occidentale, patriarcale e sessista, e dunque dal controllo sulla sessualità femminile, hanno rimosso del tutto le emozioni del corpo per le generazioni di donne che ci hanno preceduto.
Foggia – I LUOGHI della politica, dei partiti e delle istituzioni, del quotidiano tra le mura domestiche hanno sempre riprodotto la divisione dei ruoli f/m, data per scontata, un dato della natura. È così che il corpo della donna si fa supporto delle iscrizioni della cultura: limitati sono gli spazi del piacere e della sessualità, delle emozioni, delle ambizioni, della gratificazione e realizzazione di un progetto di vita, se non all’interno di ruoli ascritti a vita. I diktat imposti dalla cultura occidentale, patriarcale e sessista, e dunque dal controllo sulla sessualità femminile, hanno rimosso del tutto le emozioni del corpo per le generazioni di donne che ci hanno preceduto.
Le rappresentazioni storiche, culturali e mediatiche del corpo delle donne, di controllo sulla sessualità e delle emozioni, organizzano e strutturano nei mondi della vita quotidiana le modalità del sentire e dell’abitare il corpo: sono una produzione discorsiva, ma sono anche e soprattutto saperi incorporati, perchè di fatto hanno orientato, e orientano ancora, il sentire del corpo, le sue emozioni. Impariamo ad essere corpo, a sentire il nostro stesso corpo, nei processi di socializzazione primaria e secondaria, in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari, e in ogni contemporaneo e successivo processo di apprendimento. Marcel Mauss descrive bene questo processo del tutto artificiale di costruzione del corpo, spiega cos’è il corpo: uno strumento forgiato da tecnologie corporali, da montaggi fisio-psico-sociologici. Abbiamo ovunque nel mondo tecniche del parto, ma in tutte le culture esse sono differenti, così come differenti sono le tecniche del taglio del cordone ombelicale e le cure del neonato.
Tra le tecniche del movimento e del camminare delle donne in Nuova Zelanda da menzionare è il dondolamento delle anche chiamato onioi, che i Maori apprezzano molto. L’andatura delle ragazze francesi è oggetto di una singolare riflessione di Mauss:”Mentre ero degente in un ospedale di New York mi chiedevo dove avessi già visto delle signorine che camminavano come le mie infermiere, mi ricordai che le avevo viste al cinema. Tornato in Francia notai soprattutto a Parigi la frequenza di questa andatura: le ragazze francesi camminavano nello stesso modo, in effetti grazie al cinema il modo di camminare americano cominciava ad arrivare anche da noi”.
Una osservazione rilevante nelle nostre riflessioni critiche su come i media siano canali che amplificano la direzione e la dimensione delle scritture della cultura patriarcale sul corpo delle donne. Tra le molte tecniche del sesso, continua Mauss, possiamo osservare che la sospensione delle gambe all’altezza delle ginocchia, diffusa in tutto il Pacifico, è rara altrove. Più in generale durante l’atto sessuale sono molte e differenti le tecniche per il respiro, per il bacio e così via.
Conclude Mauss: “Da esse risulta che ci troviamo di fronte a montaggi fisio-psico-sociologi di una serie di atti che in ogni società ciascuno deve sapere e imparare“ [407]. L’insieme delle tecnologie corporali rivela dunque la natura non naturale delle tecniche del corpo.
Ancora voglio citare due concetti importanti che mettono bene a fuoco il concetto di corpo come testo, come costrutto culturale. Il primo è il mindful-body, corpo pieno di mente, di Nancy Scheper-Hughes (1987). Il secondo è l’incorporazione, embodiment, dell’antropologo Thomas Csordas (1994).
In un articolo di Nancy Scepher Hughes pubblicato nel 1987, The mindful body, il corpo è definito come costruzione in fieri nell’intreccio tra dinamiche di produzione, riproduzione e reinvenzione culturale; il luogo in cui sono sì sedimentate le pratiche di controllo dei poteri forti sulla sessualità e sulle emozioni, ma anche e soprattutto il corpo è il luogo dell’esperienza, è un corpo-pieno-di-mente, esperienza sensoriale, tattile, visiva, olfattiva.
Il corpo delle donne è dunque – all’interno di una cornice normativa che ha delimita i confini del normale e del deviante, del piacere e della sessualità – una costruzione sociale e politica in cui si intrecciano linguaggi, simboli e assetti sociali, che hanno eradicato, nella storia delle generazioni di donne che ci hanno preceduto, il sentire le emozioni del corpo.
Il secondo concetto-termine che voglio analizzare è embodiment, incorporazione, dell’antropologo Thomas Csordas, che descrive sia un’attitudine del corpo alla incorporazione di tecniche e dispositivi sociali di controllo sul corpo e sulla sessualità, ma anche la resistenza ai dispositivi di controllo dei poteri e dei saperi sul corpo, ai codici comportamentali, ai divieti e alle prescrizioni corporali. Ovvero: il corpo è sia presenza e progetto nel mondo, produzione corporea che oppone resistenza ai divieti della cultura patriarcale e sessista, che sedimentazione dei linguaggi e delle pratiche dei poteri forti sul corpo. Negli interstizi tra acquiescenza e resistenza all’ordine costituito delle biopolitiche sui corpi si fa spazio allora una politica di liberazione possibile del corpo delle donne.
Dunque il corpo è un testo della cultura, un artificio, arte-fatto, che possiamo riscrivere, e così ribaltare i saperi e le culture egemoni del corpo, la divisione dei ruoli di genere nella cultura occidentale, patriarcale e maschilista, la costruzione delle differenze, le modalità dell’abitare un corpo. I codici vestimentali e corporali, dalla body-art al piercing e al tatuaggio, sono esempi di reinvenzione creativa di corpi.
Ma se il corpo è una costruzione politica e culturale allora anche la differenza di genere è un artefatto della cultura. Essere donna non è allora un dato della natura, come viceversa è l’essere femmina. E questo spiega perché l’identità di genere è molto spesso ibrida, transitoria, come nel transgenderismo e nel transessualismo, ma anche nella più normalizzata, borghese e bigotta, identità maschia ed eterosessuale, bianca e occidentale, che tanto più si erige a tutela dei confini rassicuranti del noi, della famiglia patriarcale – l’unico modello di famiglia che abbiamo imparato a riconoscere, dato per scontato – quanto più è minacciata dall’invadente presenza dell’alterità: l’omosessuale, il trans, la lesbica, la donna bianca o di colore.
Così, mi chiedo quale differenza di genere possiamo mai rivendicare? Ci hanno insegnato a “fare le femmine”, come se fosse questo l’unico modello possibile. E come se fosse tra l’altro possibile ridurre a un organo, l’utero, l’identità, di cui mai nessuna donna ha avuto contezza se non al primo dolente mestruo.
E dunque, una politica delle donne, per le donne, che intenda restituire dignità all’altra metà del cielo pari opportunità nei luoghi della politica, dei partiti, del lavoro e nella privatezza della mura domestiche, deve ribaltare secoli di iniquità, disparità, repressione del corpo e della sessualità, con un atto politico di liberazione di tutti i corpi e di tutte le differenze, di sesso e di genere, di status sociale e di ruolo.
Restituendo però alla natura il suo ruolo, perché le differenze di sesso sono un dato della natura, le seconde, quelle di genere, status e ruolo, sono un artificio, un testo della cultura che possiamo riscrivere nelle forma che più aggrada, e con la forza liberante del desiderio.
La costruzione delle differenze di genere, di razza, colore, di status sociale, ha consentito infatti dentro rapporti di potere, di dominio e subordinazione alla struttura sociale di stratificarsi in un certo modo, così se sei femmina, di colore, povera, lesbica e, ciliegina sulla torta, la cicogna ti molla in determinata collocazione geografica, hai accumulato in sol colpo una serie infinita di sventure. Massimo Canevacci così commenta una poesia di Pessoa: “Assumere diverse identità e disvelare attraverso questa opera di auto-nominazione moduli narrativi diversificabili, mai raggruppabili nella sintesi unificata del soggetto”.
In questo e altri testi l’antropologo suggerisce la molteplicità dell’io, non una identità fissa, immutabile, piuttosto l’identità è un processo non riconducibile all’identico, all’identità anagrafica, l’identità plurale è un farsi altro. Una bella sfida alle identità di genere dicotomiche, alle opposizioni binarie delle identità di genere m/f, pensate come luoghi separati, ma attraversate dal soggetto, come di fatto è nelle evidenze dei mondi della vita quotidiana.
A questo punto della storia che vi sto narrando, quella delle identità come attraversamento piuttosto che come dato della natura, chiedo: è mai possibile pensare una politica di genere come portatrice di una differenza politica?
Se la costruzione dell’identità di genere è nulla più che un artificio della cultura occidentale che riproduce la separazione dei ruoli e assegna etichette, categorie – che tuttavia hanno una rilevanza, orientano la nostra percezione, il riconoscimento delle cose del mondo – allora una politica delle donne del tutto aderente alle categorie dicotomiche e ai ruoli cristallizzati di genere della cultura patriarcale, sessista, razzista e omofoba, non può che riprodurre le stesse strutture non equitative in termini di diritti da cui viceversa quella politica intende liberarsi.
Il 9 e il 10 Luglio, a Siena: qualcuna ha sottolineato in primo luogo che la selezione, e dunque la visibilità mediatica, delle primedonne di partito di destra e di sinistra è una scelta di parte della regia del comitato promotore, dunque discutibile, in secondo luogo che il riferimento ad un generica “differenza di genere” è fumoso, che ognuna di noi è portatrice di una peculiare differenza, di peculiari competenze e qualità da valorizzare. E se il movimento delle donne non è questo è ancora una volta il nulla della politica, di quella politica che intendiamo cambiare nella visione e nelle pratiche.
Le mie riflessioni vanno nella stessa direzione: ci accomuna una sofferenza individuale e collettiva ogni volta che la libertà delle donne, perché donne, è circoscritta dentro i confini di un ruolo che ci sta stretto: trastullo per il piacere e le ambizioni del maschio, in famiglia, sul lavoro, nel pubblico e nel privato.
Corpo mutilato, come di fatto è nei paesi dell’africa subsahariana con le mutilazioni dei genitali femminili – o nel dogma della verginità che nella nostra cultura gli fa da eco – affinchè il controllo sulla sessualità, la riproduzione e la discendenza siano espressione del potere e proprietà assoluta del maschio, padrone e signore.
Ma anche abbiamo contezza di donne che della politica hanno incorporato i codici del padre- padrone. Perché il potere, o meglio la potenza, non è né maschio nè femmina, né donna né uomo, è di chi lo possiede e la usa. E molte sono le donne che non si sottraggono al gioco, o meglio al giogo.
La visibilità mediatica a Siena il 9 e 10 Luglio delle primedonne della politica e dei partiti la dice lunga, racconta che i limiti di tempo e di spazio sul palco per alcune sono più uguali che per altre. Come è stato per Rita Saraò per esempio, la più uguale di tutte: neanche il tempo minimo concesso dal regolamento, tre minuti, forse perché, dico forse, è la portavoce del movimento delle donne per la rivoluzione gentile di Nichi Vendola? (Rita Saraò, portavoce del movimento delle donne per la rivoluzione gentile di Nichi Vendola, parte attiva della fabbrica di Nichi di Foggia, ha preso la parola durante la manifestazione di Siena. Le è stata letteralmente strappata dopo neppure i tre minuti canonici, fissati come limite cronologico, ndr)
Allora di quale politica per le donne stiamo parlando? C’è una buona politica che sia femmina e donna ? il partito o la partita? Declinando al femminile diamo una risposta alla domanda di buona politica? La buona politica, le buone pratiche di partito, non hanno, almeno per me, nè sesso né età anagrafica, sono piuttosto costruzione collettiva di uomini e donne, giovani – e diversamente giovani – che hanno un obiettivo comune e condiviso: la progressiva conquista di margini di felicità, il passaggio da un progetto politico e culturale di una società altra, da un processo collettivo di costruzione sociale, alla dimensione concreta del fare le politiche del lavoro e del welfare che restituisca a ciascuno non solo la nuda vita, ma la dimensione dell’esserci nel senso pieno del termine.
L’evento di Siena, e ancor prima il 13 Febbraio, ha rimesso in gioco molte delle istanze del femminismo: la risposta c’è stata, nelle piazze di tutta Italia, nella piazza di Siena. Il “Se non ora quando” ha offerto, ad una riaccesa sensibilità politica delle donne, canali, codici e linguaggi espressivi, rimescolando nuove e meno nuove istanze del Sessantotto e del post Sessantotto. Sulle motivazioni soggettive che hanno animato quelle piazze s’è scritto già molto. Penso che riassumerle tutte sia impresa sovraumana, ma il dato che io voglio rilevare voglio assumerlo nella categoria del risveglio individuale e collettivo. Finalmente!
Ultima riflessione, e concludo, sulla percezione da più parti emerge: ovvero che l’antipolitica serpeggi in qualche modo nel movimento. E qui rammento Rosy Bindi fischiata il10 Luglio a Siena quando sul palco racconta di sé e del suo ruolo di presidente del PD. Non dobbiamo confondere, io ritengo, la differenza tra l’antipolitica, un generico diffuso sentimento di rifiuto alle politica tout court, e la critica più costruttiva alla degenerazione e alla insufficienza delle pratiche politiche nei luoghi e nelle stanze dei palazzi e dei partiti. La prima raccoglie il dissenso ma non lo rielabora, né in una visione alternativa né in una pratica possibile. La seconda dovrebbe sollecitare una critica politica all’insufficienza dei partiti, indurre a riaggiornare la nostra lettura del presente.
La frammentazione del tessuto sociale e la frammentazione dei luoghi di aggregazione sociale e politica è il dato che oggi è più evidente a chi voglia cimentarsi in un’analisi, non dico sociologica, almeno attendibile della realtà sociale. A questa frammentazione mai potrà corrispondere un unico e grande contenitore che accolga in sé ogni possibile differenza, ogni possibile istanza. Comitati, movimenti, associazioni, aggregazioni momentanee, formali e informali, femminili e non, piccoli e grandi partiti – sottolineo non più di massa – che si attivano all’unisono e/o su temi specifici, sono quel popolo che alle amministrative e al referendum ha dato la prima vigorosa spallata al governo centrale.
In questo quadro inevitabilmente non conta il partito di massa, ma la capacità di interpretare le istanze dei corpi e la loro differenza, e incarnare il pathos, la sofferenza sociale, la domanda di un futuro plausibile e compatibile con la dimensione glocalizzata delle politiche, anche e soprattutto la delusione – diciamo pure disperazione – per quel che sono diventati oggi i partiti, spazi di competizione in cui emergono non tanto un’idea plausibile di amministrazione della cosa pubblica, quanto piuttosto – e spesso purtroppo come unica evidenza – particolari ambizioni di questo o quel notabile di partito, trame più o meno manifeste di relazioni particolaristiche a sostegno di progetti individuali di vita e di carriera.
Una politica inclusiva deve passare dalla manifestazione d’intenti alla elaborazione di una possibile via di uscita dal partito come fine piuttosto che, come dovrebbe essere, strumento della politica. Solo allora riaprire la partita, o il partito, avrà senso politico e direzione. E solo allora le passioni politiche di uomini e donne oggi riemerse dal lungo reflusso degli ultimi venti anni avranno nello strumento primo della politica, il partito, un luogo e uno spazio di dicibilità, ma anche e soprattutto di libertà di elaborazione, progettualità ed espressione politica.