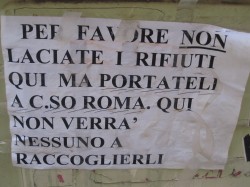Se ci sono dei libri che posseggono occhi in cui guardare, allora “Palestina” è uno di quelli. Edito dalla casa italo-tedesca Zambon e racchiuso in una preziosa edizione che non metterla in mostra è un peccato, il testo non si limita soltanto a raccontare tutta la storia (attraverso un quadro completo e puntuale ed una narrazione articolata e corale) triste e rabbiosa di una terra rabbuiata dal grigiore delle bombe. Una striscia di mondo che appartiene più alla storia che alla geografia. Con tutto il suo carico di dolore, il suo portato di sofferenza, il suo fardello di pietre e di morti bambini. Ma fa di più: evoca.
“Palestina” è più di un libro, è l’enciclopedia di un massacro; è una rivelazione. Per quella sua capacità di tenere dentro, nelle sue pagine patinate, la cronologia lancinante di depurazione etnica, la crudeltà bestiale del sionismo nascente e la forza evocativa delle immagini. Quelle foto che, da sole, sarebbero bastevoli prove di un’ingiustizia in bilico fra crudeltà, sterminio programmato e principio politico. Emblemi di una violenza indiscriminata, macelleria etnica senza scrupoli, che rifiuta la sottomissione alla tenerezza verde dell’età. Bambini schiacciati e madri frantumate.
Soffia un vento funesto fra le dita di chi legge. Soffia comprensibilmente, parlando di guerre antiche e rivendicazioni divenute diritto. Soffia blaterazioni di vendetta e superiorità, nazismi mediorientali in note minori. Le epigrafi dei padri del sionismo, accostate agli scatti del popolo dei sottomessi, intonano un canto di morte. Il requiem del diritto alla terra è inno alla distruzione delle maggioranze. Ben Gurion e Ariel Sharon uniti in un unico progetto di sopraffazione, mentre mogli e madri vedono partire e morire i loro uomini: i “vermi” condannati svanire in una nuvola di sabbia e polvere da sparo si portano dietro il loro presente insieme con il loro futuro. Un progetto che, si smonta e si riassembra di volta in volta, di epoca in epoca, di governo in governo. Per finire, poi, ad avere sempre la stessa connotazione funerea di un ceppo cinerario. Sabra e Chatila, la prima e la seconda Intifada, Piombo Fuso.
Sono stelle di un’astrologia che non prospetta nulla di diverso dalla sventura. A farne le spese, anche Vittorio Arrigoni, di cui il testo riporta testimonianze di “Restiamo Umani”. Umani come gli adolescenti intubati colpiti dai proiettili di gomma dell’esercito più equipaggiato del pianeta; umani come i cuccioli di uomo sfigurati dal “napalm like”; umane come le schiere delle genti massacrate a botte di calci, pugni e pestaggi, tratte in arresto e scomparse nelle gole profonde delle carceri israeliane (dopo aver subito altri maltrattamenti al limite del bestiale).
Quel che rende “Palestina” degno di esser letto è la sua libertà di non scendere a compromessi con la storia recente, di non farsi abbagliare dal fulgido apparire dei meetings, degli incontri internazionali, dei finti trattati, delle dichiarazioni mediatiche. “Palestina” esce dagli schemi dicotomici delle culture contro. Cessa di parteggiare per la causa occidentale e di propagandare il modello euro-statunitense come l’unico possibile per la redenzione del dolore arabo. Semplicemente, “Palestina” narra la verità, spogliata dei gingilli ipocriti e falsificatori. Porta alla luce i veri sentimenti in circolo nella striscia di Gaza, ai posti di blocco, sulle torrette di controllo. Schegge di stupro territoriale e politico in cui i soldati masticano il gusto acidulo dell’odio commisto all’acre sapore del sangue.
Racconta una soldatessa di aver sputato su un palestinese: “Non mi aveva fatto niente, stava solo passando. Ma era approvato che io lo facessi, ed era la sola cosa che potevo fare: sai, mica potevo vantarmi di aver catturato un terrorista, però potevo sputare addosso a loro, degradarli, deriderli”.
C’è chi la chiama esportazione democratica. AA.VV, “Palestina. Pulizia etnica e resistenza”, Zambon 2011
Giudizio: 4 / 5 – Resistente
LINK: http://www.statoquotidiano.it/11/06/2011/macondo-la-citta-dei-libri-38/50609/



.jpg)