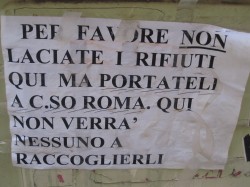Tratto – rivisto e corretto – da Piero Ferrante, La storia taciuta del popolo di Capitanata. Foggia e la Capitanata nel primo quinquennio post fascista (1943 – 1948), di prossima pubblicazione e già pubblicato a puntate sulla rivista “Sudest Quaderni”

I Gangsters dell’aria: la Guerra prima del 25 luglio
La guerra scosse per la prima volta la provincia di Foggia in un triste giorno di primavera. Era il 28 maggio 1943. E, ignara, la popolazione dauna ancora non sospettava neppure la luttuosità a venire. Sino ad allora il dolore, gli stenti, la paura e la morte sembravano infatti lontani, relegati in un orizzonte distante. Certo, la guerra imperversava ovunque, seminava morte sui campi di battaglia. Ma la Russia, l’Europa e finanche il Nord Italia apparivano delle realtà, sebbene atroci, tuttavia remote, che entravano nella quotidianità, spesso, soltanto di riflesso. Ogni mamma, è vero, aveva almeno un figlio al fronte; ogni padre nel lavorare il campo o nel trasportare il carretto, scrutava l’orizzonte col pensiero rivolto alle lacrime mai versate per infondergli coraggio; ogni bambino sognava di imitare le imprese dei fratelli maggiori, eroi involontari di una Patria capace di prendere e mai di dare ed intanto, stando ad alcuni racconti che, tramandati oralmente, sono destinati all’oblio eterno, immaginavano di compiere imprese facendo la spola tra la canonica e la propria casa. Erano tempi difficili, quelli quando la fame era compagna quotidiana, quando si correva ad ascoltare la radio del fascio nella speranza di notizie che assicurassero la guerra lontana dal proprio familiare, e ci si rivolgeva, come ad un santo, a chi potesse averne. Eppure, anche allora, la morte, per usare un’espressione di Gloria Chianese, rientrava nell’ambito dell’ineluttabilità: infatti, «se la morte di un familiare in Grecia, in Africa e nei Balcani era considerata un evento doloroso, era accettata come tradizionale ed inevitabile conseguenza della guerra». Ma questa “nuova guerra” assunse immediatamente connotati estremamente diversi, ad esempio, da quelli della Grande Guerra. E nella sua enorme sproporzione di potenziale distruttivo, nella sua drammaticità vivisezionatrice delle famiglie, cambiò la percezione stessa della morte. Agì sull’inconscio di una popolazione abituata a non fuggire per vivere, usa a dettarsi i bioritmi nell’alternarsi delle stagioni e delle ore e non nelle sirene antiaeree, avvezza a respirare l’aria pura del mattino o a soffrire la calura del giorno estivo e non quella mefitica del rifugio. La morte in casa, luogo inviolabile in quanto sede del valore più grande per il popolo di Capitanata (la famiglia), era impensabile. Ed inaccettabile. Ma, a partire da quel fatidico ventotto, divenne drammatica abitudine. Non avevano suscitato particolare allarme le uniche due incursioni effettuate, prima di allora, senza vittime, né danni eccessivi, nei cieli di San Severo (13 febbraio) e su Celenza Valfortore (13 marzo). A Foggia, in particolare, le sirene municipali suonavano ogni mattina quasi come fosse un atto scaramantico. Tutti i giorni, alle 10, ne veniva piuttosto testata la corretta funzionalità. C’era perfino un codice stabilito: sirena continua segnalava un allarme semplice, sirena a singhiozzi (con suono intermittente e rauco) un pericolo effettivo ed imminente. Le difese precauzionali erano scarse, nonostante l’importanza strategica della città data la sua posizione di ponte tra nord e sud e di appoggio verso l’est e la massiccia presenza di soldati tedeschi, circa 2000 unità tra soldati e civili e, soprattutto una media di 200 velivoli, di cui 133 della sola Stukaschule. A riprova della sicurezza dei cieli foggiani, sopravviveva allora l’atavica convinzione che né terremoti né carestie potessero superare la protezione eretta dalla Madonna Dei Sette Veli, protettrice del capoluogo. Mai come in questo frangente storico tale sicurezza venne sfatata e mai fu tanto fatale in termini di vite umane soppresse dal cieco furore di un nemico che non conosceva le tradizioni e non credeva nelle leggende. In quel primo drammatico giorno di maggio non ci fu il tempo né di far suonare le sirene, né di appellarsi alla Madonna. Alle 8,30, nell’ora di maggior viavai per studenti e lavoratori, tre formazioni di Fortezze Volanti (le formazioni aeree d’attacco dell’aviazione anglo-americana) ognuna di 20 – 30 apparecchi, ruppero i ritmi della vita quotidiana, squarciarono il cielo primaverile di Foggia e portarono morte e distruzione. I bersagli individuati da mesi di silenziose ricognizioni nei cieli della Capitanata (l’ultima, sfuggita a tanti, il 24), vennero colpiti: a ripetizione, l’aeroporto Gino Lisa, la Ferrovia, la cartiera e l’adiacente Centro Chimico Militare tedesco, persino lo Stadio Zaccheria funsero da bersagli immobili. Foggia, che solo tre giorni prima era stata deliziata dalle note del “Rigoletto”, interpretato al “Teatro Flagella”, dal baritono Gino Bechi, dal tenore Antonio Salvarezza, dalla soprano Liana Cortini, fu costretta a dimenticare il suono armonioso degli strumenti ed a stuprare le proprie orecchie con l’assordante rumore della morte. E fu solo l’inizio di quella strategia di guerra che, nel giro di appena quattro mesi, stritolò passato, presente e futuro di un’intera provincia e delle sue genti. Il giorno seguente, oltre ad un reiterato e più violento attacco aereo sul capoluogo, ci furono mitragliamenti anche nell’agro di Lucera – S.Severo e nei pressi di Sant’Agata di Puglia, che seppero molto poco di guerra e molto più di terrorismo. Emblematico, nonostante la retorica di regime, fu lo sdegno riportato in un articolo de La Gazzetta del Mezzogiorno del 30 maggio riguardo proprio la ferocia usata contro i civili di alcune campagne in territorio di Lucera:
Mentre si svolgevano fervidi ed operosi i lavori nei campi, a mezzogiorno i gangsters dell’aria hanno fatto la loro apparizione anche nel cielo […] di Capitanata. Così nei dintorni di Lucera qualche contadino è stato mitragliato nelle campagne. La stessa sorte subivano una ventina di muli.
La vicenda non mancò di suscitare sdegno a livello nazionale tanto che anche Il Corriere della Sera dello stesso giorno riportò, con identica enfasi, la notizia dell’eccidio di Lucera, e il baritono Gino Bechi donò «al Segretario Federale [di Cerignola] ben 5000£ per gli orfani delle vittime della criminale incursione nemica su Foggia». Quella anglo-americana fu una mossa studiata, pensata, ponderata; fu il risultato della mente di un carnefice più che di un soldato: il «comandante di rozzi principi [che] non aveva dubbi intellettuali né scrupoli morali sulla validità della politica del bombardamento a tappeto» (John Keegan, Uomini e battaglie della Seconda Guerra mondiale 1939 – 1945. Le strategie, le operazioni, le armi, Rizzoli, Milano 1989, p. 425), l’Air Chief Marshal Travers Harris, Capo dei Bombardieri della Royal Air Force, che gli stessi inglesi denominarono “Harris il Bombardiere” o, come ricorda Antonio Guerrieri, “il macellaio”. Trovandosi in posizione di assoluta preminenza tra le truppe alleate, riuscì ad affermare, come necessaria per la vittoria finale, la strategia dei «bombardamenti a tappeto», che prevedeva l’annientamento totale del nemico attraverso una costante e tenace attività di rastrellamento aereo delle città. A suo modo di vedere, era fondamentale per l’evoluzione bellica, il coinvolgimento e lo stravolgimento, non soltanto della vita militare del popolo nemico, ma di tutto ciò che lo riguardasse. E fu così che, loro malgrado, i civili foggiani si stritolati in un meccanismo becero e violento, avviato irreversibilmente verso la soluzione estrema. Il Comandante teorizzò, a tal proposito, che fosse necessario «sconvolgere l’esistenza delle popolazioni, con distruzioni indiscriminate e non selettive» da attuarsi mediante «bombardieri strategici d’ alta quota e velocità (le Fortezze volanti B.17 o i Liberators B.24), in gruppo. Ogni formazione costituita da 18 o 21 veicoli i quali […] sganciano il loro carico di bombe contemporaneamente…». E tale progetto dissennato, in Capitanata, riuscì più devastante che altrove. Le azioni aeree si susseguirono con una cadenza giornaliera per diverso tempo. Infatti, dopo il 28 e 29, nuove incursioni si verificarono il 30 con le stesse modalità. Giulio Castelli, su La Gazzetta del Mezzogiorno del primo giugno scrisse:
Il nemico aveva obiettivi prestabiliti […] i quartieri di abitazioni che si trovano lontani da qualsiasi obiettivo militare… Dappertutto le popolazioni sono colpite, inseguite, crivellate nelle campagne, nelle case coloniche, nei casolari dell’agro, nei comuni sperduti, con forme di autentica cannibalesca caccia all’uomo (Giulio Castelli, “L’infuriata ferocia dei Liberatori”, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 1 giugno 1943)
Ma se le parole dell’articolista che, a sostegno della sua tesi, cita anche la definizione di «assassini dell’aria» usata sul Giornale d’Italia, sono indubbiamente da considerarsi in un ottica di parzialità vista la chiara connessione alle finalità e, più in generale alla politica del regime, devono necessariamente essere valutate con maggior attenzione quelle della popolazione civile, vero termometro nelle situazioni calde, soprattutto alla luce del fatto che, nella città di Foggia, tre cittadini su cinque non si riconoscevano più nella politica del fascismo e 9 ferrovieri su 10 erano apertamente antifascisti. Secondo quanto riportato dal diario di Padre Tempesta traspare, però, un chiaro disappunto dei foggiani innanzi alla distruzione della città e una forma di insofferenza verso coloro che amavano definirsi “i liberatori”:
Padre, questi sono i liberatori americani? Questi sono i galantuomini inglesi?…Ecco, uccidono gli innocenti, distruggono le nostre case, ci ammazzano! (Padre Odorico Tempesta, Foggia nelle ore della sua tragedia, Edizioni del Rosone, Foggia)

Per un popolo abituato a convivere con tutti, cordiale, ospitale e, in fondo, ingenuo, tutto ciò era inammissibile. Il fascismo chiese gli uomini migliori in cambio di poche ed inutili terre, in cambio di una gloria imperitura dalla forma di medaglie e titoli di eroismo con cui le donne non poterono riscaldarsi nelle gelide notti d’inverno ed i figli non poterono giocare, trasformò le loro città in feudi di soldati tedeschi e loro, silenziosi, lo accettarono. Ed in silenzio morirono anche per tutto il mese di giugno fino al 16 e al 22 luglio, ed ancora il 19 agosto, apoteosi di una storia dolorosa che, unico caso in Italia, spopolò del tutto una città lacerata allorché, significativamente, andarono via, verso porti più sicuri, anche i Santi Protettori: l’Iconavetere e le reliquie dei Santi Guglielmo e Pellegrino, difatti, ripararono a San Marco in Lamis. Distruzione, fame, povertà, morte: questa l’eredità che la guerra lascerà alla Capitanata con uno strascico lungo almeno un decennio.
“La vera rivoluzione”: la guerra fino all’armistizio
L’ incrollabile «fede Fascista e di profondo patriottismo della Capitanata» (“I gangster dell’aria: l’alta fede di Foggia fascista”, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 giugno 1943), pomposamente messa in luce su La Gazzetta del Mezzogiorno del 4 giugno 1943, iniziò a vacillare sotto i micidiali colpi dell’aviazione anglo- americana. Le bombe di luglio furono le più letali. Il 16, nei bombardamenti degli aeroporti e della ferrovia, perirono 1.293 persone; mentre 7.643 furono le vittime accertate dell’incursione del 22, quella tristemente più nota. Chi poté andò via, altri misero in salvo, per lo meno, donne e bambini. La città si svuotò quasi interamente causando l’immobilismo anche nei servizi pubblici, tanto che il comandante del IX Corpo d’ Armata, il generale Armellini, si vide obbligato ad ordinare il ritorno forzato nel capoluogo di tutti i funzionari, impiegati ed addetti ai servizi pubblici e, quasi per dare una dimostrazione di forza al nemico mediante la continuazione della normalità di una vita incapace di arrendersi anche dinanzi alle bombe, ai negozianti a agli artigiani. Ma Foggia, indubbiamente il centro più colpito nella provincia e nell’intera Puglia, non poté non fare i conti con le sue ferite laceranti. Il cuore della città era piagato. La maggior parte delle abitazioni, dei negozi, delle vie di comunicazione, erano state squartate dalle bombe e ognuno piangeva un caro, un amico, un congiunto più o meno prossimo, perito sotto i grappoli mortali dell’aviazione nemica, di quegli apparecchi che, scherno del destino, portavano un nome incoraggiante quanto beffardo: Liberators, i Liberatori… In più, nei giorni successivi ai bombardamenti, si susseguirono varie esplosioni: erano gli ordigni a scoppio ritardato che assolvevano con regolare efficacia alla loro missione di morte. La distruzione finì per prestare il fianco alla diffusione dello sciacallaggio tanto che, L’Azione Democratica, settimanale politico lucerino vicino alle posizioni del Partito Liberale, a posteriori (siamo nell’agosto del 1944) parlò della nascita dell’associazione denominata «Amici del Furto» (“Tutta Foggia ne parla! ma?”, in L’Azione Democratica, 5 agosto 1944). La speranza di una svolta ad una guerra oramai persa venne infusa, nei foggiani, dalla notizia, diffusa nella mattinata del 25 luglio, della caduta del fascismo e dell’arresto del Duce. La fine del regime fece credere nella possibilità della fine di una guerra devastante e devastatrice, nella fine della fame, delle file interminabili, tessera annonaria alla mano, per dividersi quel poco che la Patria poteva dare, nella fine della barbarie, delle bombe, della morte;e fece credere nel ricongiungimento delle famiglie. La Gazzetta del Mezzogiorno del 28 luglio titolava, abbastanza emblematicamente: L’ITALIA HA FINALMENTE LA SUA VERA RIVOLUZIONE. E, inneggiando alla ritrovata libertà: Un solo dovere: riconquistare la Patria e noi stessi!
Iniziò così il Governo Badoglio, la grande illusione di una libertà che, però, non arrivò mai. Le norme di disciplina, compresi il coprifuoco e l’oscuramento vennero, in taluni casi, addirittura inasprite; la tessera annonaria continuò ad essere ancora l’unico cordone ombelicale che vincolava la gente alla speranza. Un documento della Questura di Foggia indirizzato, nell’agosto del 1943, ai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, San Severo e Cerignola, stabilì l’oscuramento dalle ore 21 alle 5,30. Norme esagerate (il motivo ufficiale era il riposo dei militari) anche se paragonate con quelle fasciste: basti pensare che, in un dispaccio questurino del 31 marzo del ’43, l’oscuramento, con inizio alle ore 21,30, poteva già concludersi alle 4,30 facilitando, certamente, gli spostamenti di tutti i lavoratori che, soprattutto dai paesi della Provincia dovevano recarsi nel capoluogo. Inoltre, stando alle indicazioni dettate da Badoglio, venne vietato qualsiasi assembramento pubblico, giudicato potenzialmente eversivo: chiunque violasse le norme ed i comportamenti da lui stabiliti, rischiava la morte perché
qualunque riguardo nella repressione sarebbe pertanto un delitto[…]poco sangue versato inizialmente risparmierà fiumi di sangue in seguito[…]non è ammesso il tiro in aria, si tira sempre a colpire[…]i caporioni dei disordini siano senz’altro fucilati[…]il militare che, impegnato in servizio, compia il minimo gesto di solidarietà coi dimostranti venga immediatamente passato per le armi[…].
Ma, nonostante queste restrizioni che, a dirla tutta, si distaccarono ben poco dall’autoritarismo del fascismo, la gente di Capitanata riprese, anche se in maniera appena percettibile, all’indomani della notizia, a tornare al lavoro, speranzosa che, con la caduta del fascismo, le truppe anglo-americane avessero assolto il proprio compito. Ma la povertà rimase. Anzi, in una città a dir poco devastata, finì per aumentare; e, con essa, inevitabilmente, i problemi connessi con l’ordine pubblico. Come detto, molti si diedero allo sciacallaggio che, purtroppo, finì per diventare la prima vera testimonianza della parte conclusiva della guerra come, poi, quello dei magazzini e degli ammassi lo sarà del dopoguerra. Il 12 agosto La Gazzetta Del Mezzogiorno riportò la notizia dell’arresto di quattro individui (tre uomini ed una donna), sorpresi «dalle pattuglie dislocate nel quartiere fortemente danneggiato dall’ultima incursione nemica (si deve immaginare che questo quartiere non meglio specificato fosse quello adiacente la Ferrovia), mentre rubavano fra le macerie». Il 19, sempre la Gazzetta, segnalò problemi di ordine pubblico a Foggia culminati con l’arresto di un ventenne per furto aggravato ai danni di un impiegato della Prefettura: entrato nella casa sinistrata dopo i bombardamenti di luglio, venne sorpreso «asportando una bicicletta» e, successivamente, di due individui che, forse affamati, forse per immettere prodotto sul mercato nero, vennero colti in flagrante mentre tentavano di sottrarre grano da un ammasso. E ancora il 29 luglio 1944, il Tribunale di Foggia condannò a sei anni di reclusione e a £5 di multa ciascuno, due germani foggiani, Ciro ed Angela Svamazio, colpevoli di aver trafugato, il 28 agosto 1943, materassi, cuscini, una macchina da cucire ed altri oggetti da una casa sinistrata rimasta incustodita. Ad infrangere le speranze furono gli accadimenti del mese di agosto. Il 16 vennero bombardati gli aeroporti intorno a Foggia (il centro cittadino, almeno stavolta, venne risparmiato), la miniera di bauxite della società Montecatini in territorio di S. Giovanni Rotondo e l’agro di Lucera. Il 19, su tutto il territorio della provincia (a quanto segnalato dal Bollettino delle Forze Armate n. 1182), su Orsara (dove ci fu anche una vittima) e su Foggia in particolare, si scatenò un bombardamento fatale per le sorti della guerra e della città dispensato nell’arco di 24 ore. Vennero colpiti il Municipio, il Palazzo del Governo, l’Amministrazione Provinciale, il Palazzo delle Poste, gli Ospedali, la Croce Rossa, numerose chiese (tra cui la Cattedrale), il Museo, i Vigili del Fuoco, il Liceo Musicale, diversi panifici, l’acquedotto, le linee elettriche, le strade urbane e migliaia di case. Praticamente tutta la città ammetteranno le Forze Armate. Altre 9.521 persone vennero stroncate d’improvviso. La BBC e la Reuter parlarono di 4.000 grosse bombe sganciate sul solo capoluogo, notizia ripresa sia dall’Eiar, sia da La Gazzetta del Mezzogiorno ed espressa in questi termini:
[…]i piloti che hanno partecipato all’incursione su Foggia… hanno precisato che tremende esplosioni hanno squassato il centro della Città, i cui edifici furono visti sommergere in un mare di polvere e di fiamme. Secondo le dichiarazioni, su Foggia sarebbero state sganciate 4000 bombe di grosso calibro
Foggia è in ginocchio. Quei pochi abitanti rimasti in città presero la strada della fuga verso la provincia. Il colpo di grazia le venne dato dalle incursioni, tutte sulla città, del 20, del 21 e, in particolare del 25 agosto che uccisero ancora più di un altro migliaio di persone. Il Bollettino del Comando Supremo n. 1188, che inquadrava come obiettivo la ferrovia e gli aeroporti, segnalò come zone colpite dai velivoli partiti dalla Tunisia, dalla Libia e dall’ Algeria, anche il centro abitato e la periferia. Gli attacchi, compiuti in cinque ondate successive, colpirono, oltre che gli impianti già danneggiati (specialmente quelli del deposito locomotive) anche la strada statale per Manfredonia, il golfo del centro sipontino (causando anche un morto) e lo scalo ferroviario di Rocchetta Sant’Antonio (altri 3 morti). Fu l’ultimo attacco consistente (in verità gli attacchi cesseranno solamente dopo la stipula dell’armistizio). La città si svuotò divenendo un deserto completo. Tutti gli uffici pubblici vennero trasferiti nei centri della provincia. La Prefettura emigrò a Bovino, poi a Lucera; il Tribunale, l’Intendenza, la Procura del Regno, l’ Ispettorato Agrario Provinciale, il Gruppo dei CC. RR., l’ Archivio Provinciale di Stato, l’Ufficio Provinciale del Lavoro, l’Istituto di Previdenza Sociale, il deposito dei cavalli stalloni sono a Lucera, dove rimasero fino al 1944; il distretto militare finì a San Severo; l’Acquedotto Pugliese, nell’edificio scolastico di Ascoli Satriano. E, così, divenne la meta favorita degli sciacalli, sia civili, sia militari. Pochi furono coloro che, nel turbinio di morte e desolazione, caricarono su spalle o carretti di fortuna, quello che avevano. Si attivò, grandezza nella sciagura, la macchina della fratellanza solidale. Migliaia e migliaia di sfollati vennero accolti nelle case di gente di paese, parenti, amici o perfetti sconosciuti, sensibili al dolore dei fratelli di città che, per la follia dell’uomo, persero tutto. A Bovino l’afflusso in massa di oltre due sfollati foggiani causò «delle gravi difficoltà dell’alimentazione […] e risultano assorbite già tutte le scorte di farina, pasta e grano» già il 24 luglio 1943. A Castelluccio dei Sauri, per la loro sistemazione, il Podestà locale dovette ricorrere all’uso di due aule scolastiche mentre ad Orsara furono approntati ripari in località Giardinetto. Sulle loro teste si svolgeva, intanto, la grande meccanica della politica. Dopo lo sbarco in Sicilia, avvenuto il 10 luglio 1943, le truppe anglo-americane, spinte dall’impetuosa golosità imperialista di Churchill, puntarono decise verso il continente. Per diverso tempo il Sud divenne il territorio di battaglia tra gli anglo-americani e le truppe italo-tedesche. Fino al giorno, insieme glorioso ed infame, dell’armistizio. È l’8 settembre quando il maresciallo Badoglio ne annunciò la firma con Eisenhower. Ebbe termine così una lotta impari che, a detta dei più, il Paese non volle; e finì, più che con un accordo militare, con un atto di resa incondizionata e disperata di un Italia annichilita, stremata e prostrata dalla durezza della guerra, annientata dalle bombe nei suoi gangli vitali. A momenti di giubilo della popolazione si unì ben presto il timore di una situazione potenzialmente pericolosa. Difatti in tutta l’Italia meridionale, dove poi si costituì il Regno del Sud con prima sede a Brindisi, i tedeschi imperavano e controllavano più o meno saldamente il territorio. È il periodo della doppia occupazione quando il Sud sarà terreno di battaglia tra due eserciti. La paura di ritorsioni efferate colse la popolazione. Iniziò, così l’ultima fase della guerra (il 13 ottobre l’Italia liberata dichiara guerra alla Germania nazista), che, se non la più cruenta, certamente fu la più barbara, fatta di ritorsioni, vendette, morti innocenti e città inermi come grandi palcoscenici di una guerra il cui risultato, ora, non era più veicolato dagli italiani. L’VIII Armata delle truppe anglo-americane (i nuovi amici che fino a ieri erano nemici) sotto il comando di Montgomery saliva da sud, da Reggio Calabria tra schiaccianti vittorie e puntava dritto su Foggia, fulcro designato per la direzione della operazioni di guerra. E i tedeschi, allo sbando, in ritirata verso nord, verso Roma, ultimo tentativo di difesa di un baluardo che voleva dire “grandezza”.







![[polenta-fritta.jpg]](https://radicaliliberi.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/08/polenta-fritta.jpg?w=300)